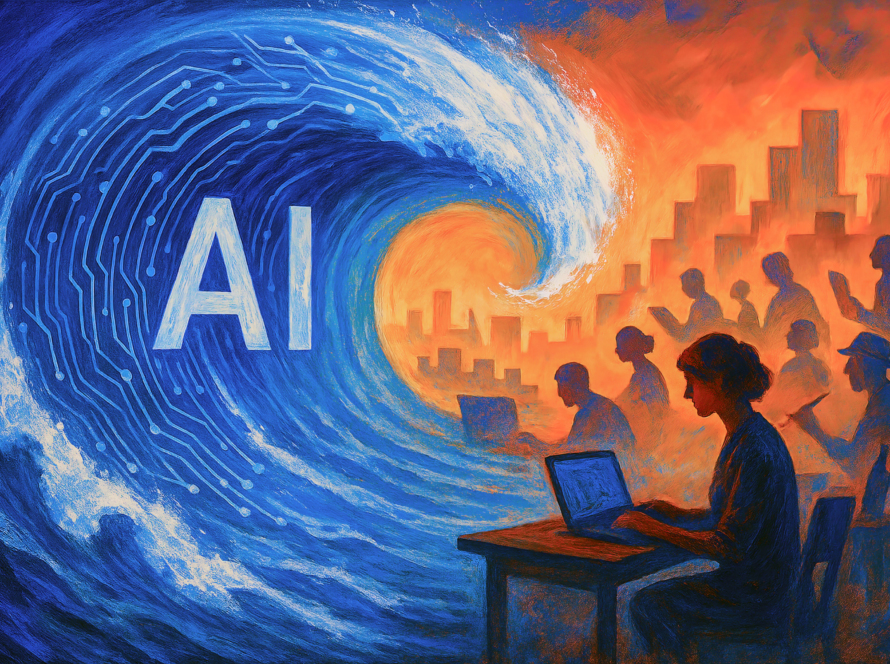Noi di Librologica abbiamo osservato l’uso dello schwa in realtà simili alla nostra. Dopo un’attenta valutazione, abbiamo deciso di non adottare questo metodo, lasciando comunque agli autori la libertà di esprimersi come preferiscono. Nella comunicazione con iscritti e clienti manterremo un approccio tradizionale, utilizzando nelle mail formule come Caro/a cliente, Gentile lettore/lettrice o Caro/a abbonato/a.
Ma come siamo arrivati a questo bivio? L’articolo vuole fare un po’ di chiarezza.
La perdita del genere neutro nelle lingue romanze: il caso dell’italiano e il confronto con altre lingue
Quando si pensa all’italiano come diretta evoluzione del latino, si potrebbe ingenuamente supporre che sia la lingua neolatina che più ha preservato le caratteristiche dell’antico idioma romano. Tuttavia, uno degli aspetti più rilevanti dell’evoluzione linguistica che ha separato l’italiano (e le altre lingue romanze) dal latino è proprio la perdita del genere neutro. Curiosamente, lingue non romanze come il tedesco hanno invece conservato il genere neutro, mentre l’inglese, pur provenendo dalla stessa famiglia germanica, lo ha completamente abbandonato nei sostantivi. Ma come e perché è avvenuta questa trasformazione nelle lingue romanze?
Il neutro nel latino e il suo declino
Il latino classico aveva tre generi grammaticali: maschile, femminile e neutro. Nel corso dell’evoluzione verso il latino volgare, la distinzione tra questi generi iniziò a sfumare. La principale causa della scomparsa del neutro fu la sua somiglianza con il maschile e il femminile in alcune forme grammaticali. In particolare:
- I nomi neutri della seconda declinazione (es. templum, vinum) tendevano ad essere reinterpretati come maschili, dato che al singolare erano simili ai nomi maschili della stessa declinazione.
- I nomi neutri della terza declinazione al plurale terminavano in -a (es. corpus → corpora), una forma identica al plurale dei nomi femminili della prima declinazione (puella → puellae). Questo ha portato alla reinterpretazione del genere.
- Alcuni plurali neutri latini sono sopravvissuti come forme femminili in italiano: brachium (singolare neutro) è diventato braccio (maschile), ma il suo plurale bracchia è stato reinterpretato come le braccia (femminile).
Alla fine del periodo tardo-latino, il genere neutro era praticamente scomparso e ogni parola era stata riassegnata al maschile o al femminile.
Il caso dell’italiano
L’italiano ha completamente perso il genere neutro nei sostantivi, sebbene alcuni residui si trovino nelle forme plurali. Oltre al caso delle “braccia”, troviamo esempi come:
- Il dito (maschile) → le dita (femminile)
- L’uovo (maschile) → le uova (femminile)
- L’osso (maschile) → le ossa (femminile, ma gli ossi quando si riferisce a ossa singole e distinte)
Anche alcune espressioni come il bello e il brutto della vita riflettono l’uso del maschile come categoria generica, funzione che in latino sarebbe stata coperta dal neutro.
Il confronto con le altre lingue romanze
Francese
Il francese moderno ha completamente eliminato ogni residuo del genere neutro. Gli antichi neutri latini sono stati riassegnati per lo più al maschile (tempus → le temps), mentre alcuni plurali neutri latini sono diventati nomi femminili (gaudia → la joie). Anche nei pronomi non esiste più un genere neutro, con l’uso di forme come ce, cela, ceci per riferirsi a concetti astratti.
Spagnolo
Anche lo spagnolo ha eliminato il genere neutro nei sostantivi, ma conserva tracce di esso nei pronomi dimostrativi neutri (esto, eso, aquello) e in un particolare articolo neutro, “lo”, usato per concetti astratti (lo bueno, lo importante). Pur non essendo un vero genere neutro, queste strutture riflettono un retaggio dell’antico sistema latino.
Portoghese
Simile allo spagnolo, il portoghese ha perso il genere neutro nei sostantivi, ma mantiene pronomi dimostrativi neutri (isto, isso, aquilo) per riferirsi a entità non specificate o concetti astratti. Tuttavia, non ha un equivalente diretto dello “lo” spagnolo e utilizza il maschile come genere predefinito.
Rumeno: l’eccezione neolatina
A differenza delle altre lingue romanze, il rumeno ha conservato una forma di genere neutro, sebbene sia descritto più precisamente come ambigenere: i sostantivi neutri si comportano come maschili al singolare e femminili al plurale. Ad esempio:
- braț (sing. “braccio”) → brațele (plur. “braccia”, accordo femminile)
- ou (sing. “uovo”) → ouă (plur. “uova”, accordo femminile)
Il rumeno è quindi l’unica lingua neolatina a mantenere una categoria neutra funzionale, con un sistema ancora produttivo nella lingua moderna.
Il caso dell’inglese e del tedesco
L’inglese antico possedeva tre generi, ma li ha persi quasi completamente nel passaggio all’inglese medio, mantenendo il genere solo nei pronomi (he/she/it). Oggi, i sostantivi inglesi non hanno genere grammaticale.
Al contrario, il tedesco ha conservato il genere neutro in pieno, con parole come das Kind (“il bambino”), das Haus (“la casa”) e das Mädchen (“la ragazza”, nonostante indichi una persona femminile). Il neutro tedesco, quindi, si è mantenuto come categoria distinta e produttiva.
Lo schwa
Negli ultimi anni, la proposta di adottare lo schwa (ə) come desinenza neutra per i sostantivi e gli aggettivi in italiano ha sollevato un acceso dibattito. La questione si colloca all’interno di un più ampio tentativo di superare il maschile sovraesteso, ritenuto da alcuni una forma di invisibilizzazione di soggetti non maschili o non binari. Tuttavia, al di là delle motivazioni ideologiche, l’introduzione dello schwa presenta notevoli difficoltà linguistiche, fonetiche e pratiche.
L’idea dello schwa nasce dalla necessità di introdurre una desinenza che possa sostituire sia il maschile che il femminile nelle forme flessive dell’italiano. Esso viene proposto per sostituire la vocale finale nelle parole che altrimenti sarebbero declinate secondo il genere binario: amicə invece di amico/amica, bellə invece di bello/bella, tuttə invece di tutti/tutte. Tuttavia, questa soluzione presenta diversi problemi.
Lo schwa non è una vocale dell’italiano standard e non ha mai fatto parte del sistema fonologico della lingua, sebbene compaia in alcuni dialetti meridionali, come nel napoletano, dove viene pronunciato in forma atona a fine parola. Questo lo rende di difficile integrazione nella lingua standard. Anche la pronuncia e la scrittura risultano problematiche: non essendo un suono familiare per i parlanti italiani, viene percepito come innaturale e artificioso. Nella scrittura, inoltre, non è facilmente digitabile su tastiere standard e viene spesso sostituito da caratteri grafici non riconosciuti universalmente.
Dal punto di vista morfologico, l’introduzione dello schwa non si adatta alla struttura dell’italiano. Il sistema di accordo della lingua è molto strutturato, e la flessione del genere si riflette non solo nei sostantivi, ma anche negli aggettivi, pronomi e articoli. Modificare solo la vocale finale non è sufficiente a garantire la coerenza del sistema, creando problemi di accordo difficili da risolvere. Inoltre, dal punto di vista dell’accessibilità, l’uso dello schwa può risultare un ostacolo. I lettori automatici per ipovedenti e non vedenti spesso non riconoscono questa vocale, o la leggono in modo errato, complicando la comprensione del testo per chi si affida alla sintesi vocale.
Sebbene il dibattito sullo schwa nasca da intenti inclusivi, il suo utilizzo viene percepito da molti come un’imposizione artificiale piuttosto che come un’evoluzione naturale della lingua. Le lingue cambiano nel tempo attraverso l’uso spontaneo e non per imposizione normativa. La diffusione dello schwa avviene soprattutto in ambienti accademici e attivisti, ma fatica a radicarsi nel parlato quotidiano. Esistono alternative più naturali e funzionali per superare il maschile sovraesteso senza modificare radicalmente la grammatica. L’uso di termini inclusivi e perifrasi, come ad esempio “il personale docente” invece di “i docenti” o “la comunità studentesca” invece di “gli studenti”, rappresenta una soluzione meno problematica. Un’altra possibilità è la rotazione dei generi nei testi ufficiali o l’utilizzo di pronomi e forme impersonali, come “chiunque voglia partecipare” invece di “tutti i partecipanti”.
L’adozione dello schwa come soluzione al problema del genere grammaticale in italiano presenta più difficoltà che vantaggi. Dal punto di vista linguistico, la sua integrazione risulta complessa e forzata, foneticamente è estraneo all’italiano standard e, dal punto di vista pratico, complica la lettura, la scrittura e l’accessibilità. Più che una reale soluzione linguistica, appare come un tentativo di intervenire sulla lingua per ragioni ideologiche. Se l’italiano dovesse sviluppare un genere neutro o una forma inclusiva alternativa, è più probabile che ciò avvenga attraverso un’evoluzione spontanea dell’uso e non tramite un’innovazione pianificata.