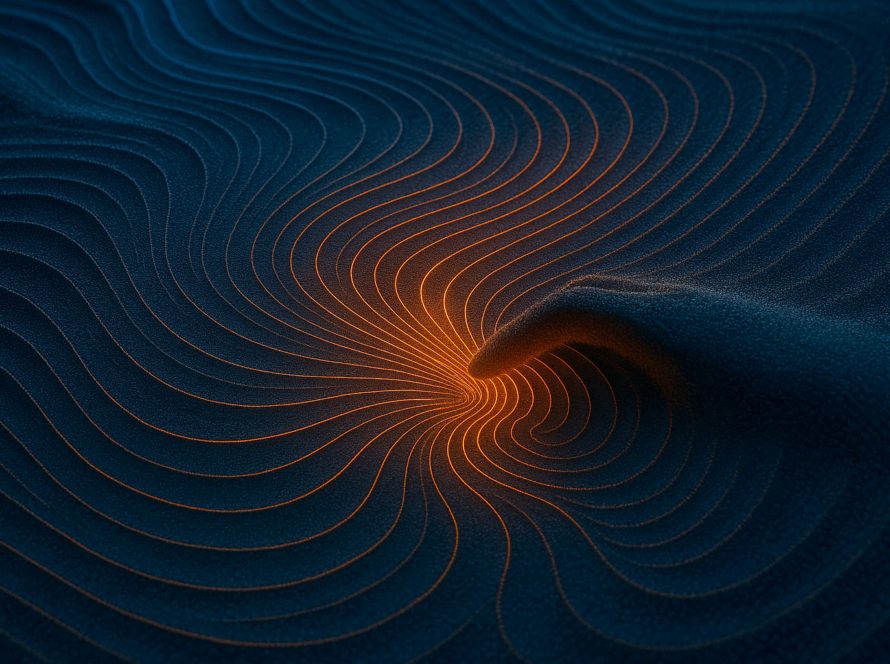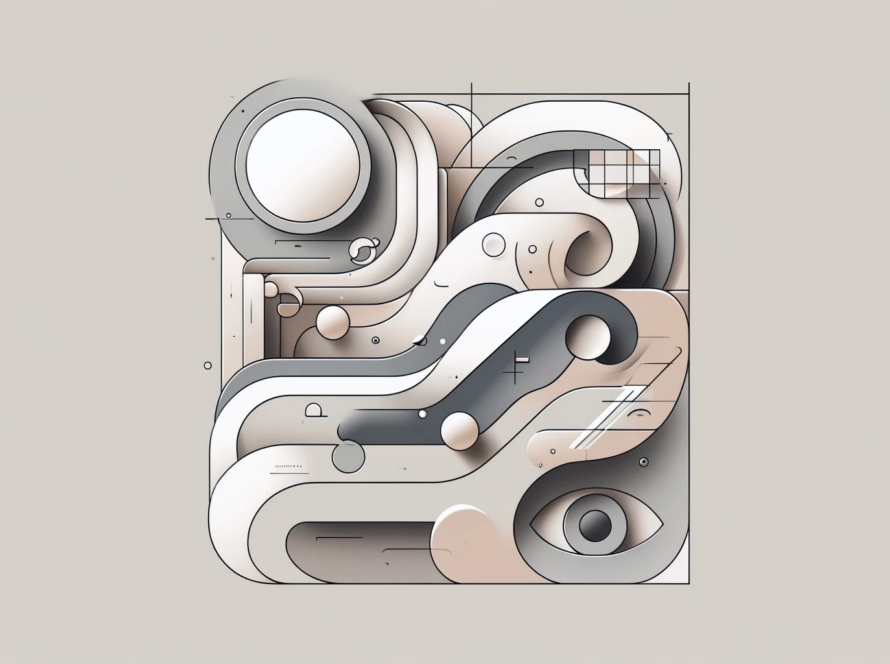Con il disegno di legge n. 1146-A (testo proposto dalle Commissioni riunite), il Parlamento italiano ha tentato una sintesi tra mondi apparentemente distanti: la velocità dell’innovazione tecnologica e la profondità delle pratiche culturali. In questo documento – frutto di revisioni, aggiustamenti e riflessioni parlamentari – si delinea una prima architettura normativa nazionale dedicata all’intelligenza artificiale, che non teme di entrare nel merito delle attività più sensibili: quelle legate alla produzione creativa.
Per chi lavora nell’editoria, nella scrittura o nella progettazione di contenuti culturali attraverso strumenti algoritmici, il testo non si limita a fornire cornici astratte. Tocca nervi scoperti. Interviene là dove l’autorialità rischia di sfumare, dove il trattamento dei dati si intreccia con l’atto creativo, dove la trasparenza verso lettori e committenti diventa una responsabilità quotidiana.
Librologica nasce proprio in questo spazio di trasformazione, osservando fin dall’inizio – in modo nativo – i principali concetti inquadrati da queste normative: la responsabilità dell’autore, la trasparenza nell’uso dell’intelligenza artificiale, la tutela della creatività umana, la chiarezza nei confronti dei lettori (Iscrivetevi gratuitamente al forum o acquistate un qualsiasi prodotto per poter scaricare il PDF sul funzionamento di Librologica.)
Il disegno di legge non chiude la porta alla sperimentazione, anzi la spalanca. Ma pone alcune condizioni irrinunciabili: la presenza di un’intenzione umana riconoscibile, la garanzia che i contenuti siano identificabili per ciò che sono, la possibilità per chi crea di assumersi la paternità – o la co-paternità – dell’opera. Dentro questa tensione tra controllo e libertà, tra automazione e originalità, si sta disegnando il nuovo paesaggio normativo per chi scrive, pubblica, elabora immagini e testi servendosi delle potenzialità dell’intelligenza artificiale.
Nel seguito dell’articolo, entriamo nel dettaglio delle disposizioni che interessano direttamente il mondo creativo ed editoriale: un terreno sempre più abitato da modelli generativi, ma ancora profondamente umano nel suo bisogno di senso, visione e responsabilità.
Il disegno di legge n. 1146-A, come modificato dalle Commissioni parlamentari, introduce norme e deleghe in materia di intelligenza artificiale, ponendo particolare attenzione all’equilibrio tra innovazione, tutela dei diritti fondamentali e sviluppo del tessuto economico. Di seguito, alcuni dei punti più rilevanti per chi opera nel settore creativo ed editoriale facendo uso di sistemi di AI.
Definizioni e principio di responsabilità umana
Nel testo, all’articolo 2, si specificano le nozioni chiave legate all’intelligenza artificiale, dal “sistema di intelligenza artificiale” ai “modelli di intelligenza artificiale”, ribadendo che qualsiasi impiego di tali tecnologie deve avvenire salvaguardando la creatività e l’autonomia decisionale dell’uomo.
Trattamento dei dati e trasparenza
L’articolo 4 sottolinea il rispetto della riservatezza e la leicità del trattamento dei dati, con particolare riguardo alla protezione dei minori. Chi crea prodotti editoriali con l’AI deve dunque attenersi ai principi di chiarezza nelle informazioni e di sicurezza dei dati elaborati, informando correttamente gli utenti sul tipo di contenuti generati.
Uso professionale dell’AI
Per gli operatori intellettuali e creativi, l’articolo 12 si sofferma sul rapporto tra lavoro umano e sistemi di AI. È previsto che chi utilizza tecnologie di intelligenza artificiale debba informare la committenza – nel caso di autori e scrittori, i destinatari della prestazione – e assumersi la responsabilità finale dell’opera. La componente umana resta predominante, nonostante l’apporto dell’AI.
Tutela del diritto d’autore delle opere generate o co-generate
Uno dei punti cardine è rappresentato dal nuovo articolo 23 (risultato del riassetto tra la versione originaria e il testo come proposto dalle Commissioni), che disciplina il diritto d’autore in caso di opere realizzate con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale. Viene riaffermato che per ottenere protezione, occorre un contributo creativo umano: l’AI può fornire supporto nella creazione o nell’elaborazione di testi, immagini e contenuti multimediali, ma la paternità dell’opera si fonda sull’originalità che l’essere umano esprime, anche quando il contenuto nasce da un processo di co-generazione.
Nel testo originario del disegno di legge, l’articolo 23 imponeva una serie di obblighi ai gestori di piattaforme digitali, soprattutto a quelle che ospitano contenuti audiovisivi. In particolare, chiedeva che venisse segnalato in modo evidente – con un simbolo visivo come l’acronimo “IA” o con un annuncio audio – quando un contenuto era stato generato o modificato da un sistema di intelligenza artificiale. L’obiettivo era quello di rendere chiaro agli utenti se stavano guardando o ascoltando qualcosa prodotto da una macchina o da una persona.
Nel nuovo testo delle Commissioni riunite, questo articolo è stato completamente eliminato. Di conseguenza, tutti quegli obblighi sono scomparsi. La scelta sembra mirare a rendere la normativa più snella e meno appesantita da regole ridondanti o potenzialmente in contrasto con quelle europee. In questo modo, si apre anche più spazio alla creatività e alla sperimentazione con l’intelligenza artificiale, senza l’imposizione di etichette obbligatorie sui contenuti.
La soppressione dell’articolo 23 lascia quindi ai fornitori una maggiore libertà su come e se comunicare l’uso dell’intelligenza artificiale nei propri contenuti. Un cambio di rotta che riduce i vincoli burocratici e potrebbe favorire l’innovazione.
Deleghe al Governo e prospettive future
L’articolo 22, infine, delega l’Esecutivo a emanare disposizioni che armonizzino la normativa nazionale con la regolamentazione europea in materia di intelligenza artificiale. L’obiettivo è rendere le future disposizioni capaci di tener conto delle rapidissime evoluzioni tecnologiche e di realizzare un quadro certo per chi sviluppa, utilizza e distribuisce opere in parte riconducibili a sistemi di AI.
Dal testo emerge un approccio aperto alla crescita tecnologica, bilanciato da precisi obblighi di trasparenza, protezione dei dati e salvaguardia della creatività umana. Per un progetto editoriale che sfrutta intensivamente l’IA, tali norme definiscono una cornice nella quale operare in sicurezza dal punto di vista legale e in modo eticamente responsabile: da un lato, si favorisce lo sviluppo di contenuti innovativi e la sperimentazione; dall’altro, si riafferma che l’autore resta garante della qualità e dell’originalità dell’opera, anche quando l’intelligenza artificiale gioca un ruolo significativo.