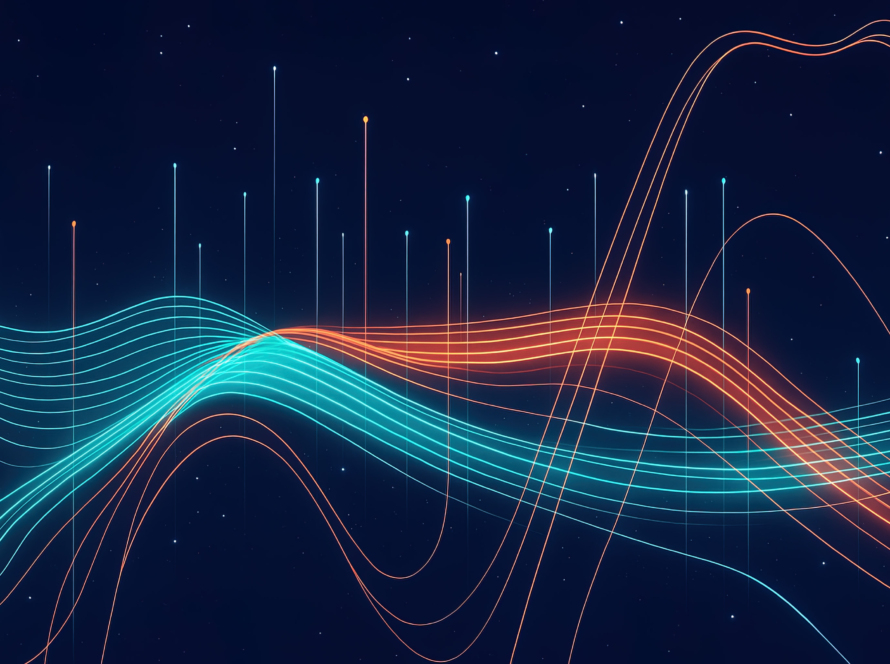La rapida diffusione dell’intelligenza artificiale generativa, capace di produrre testi, immagini e musica originali, ha innescato un’ondata di cause legali contro le aziende che sviluppano questi modelli. Autori, editori, artisti visivi, fotografi e case discografiche di tutto il mondo sostengono che i loro contenuti protetti da copyright siano stati utilizzati per addestrare algoritmi senza autorizzazione né compenso. Dal canto loro, le società tecnologiche come OpenAI, Meta e altri difendono le proprie pratiche citando il principio del fair use (uso legittimo trasformativo), affermando di impiegare dati disponibili pubblicamente in modo consentito e innovativo.
Questo scontro legale globale sta delineando i confini giuridici dell’AI generativa, in un delicato equilibrio tra tutela dei diritti d’autore e promozione dell’innovazione.
Autori e opere letterarie:
Tra i casi più noti vi sono le azioni legali intentate dagli scrittori contro OpenAI (produttrice di ChatGPT) e altri attori del settore. Nel settembre 2023 un gruppo di 17 autori di alto profilo – tra cui John Grisham, Jodi Picoult, David Baldacci e George R.R. Martin – ha avviato una class action a New York accusando OpenAI di aver violato il copyright dei loro romanzi per addestrare GPT senza licenza. Allo stesso modo, la scrittrice e comica Sarah Silverman e altri colleghi hanno intentato cause analoghe sia contro OpenAI sia contro Meta, sostenendo che i modelli linguistici abbiano assimilato interi libri protetti (compresi i loro) e ne rivelino tracce generando riassunti dettagliati delle opere – prova che tali testi sono stati copiati nel training. Gli autori denunciano un danno esistenziale alla propria professione, affermando che l’uso non consensuale dei loro libri minaccia il valore del loro lavoro e il loro sostentamento. Queste cause sono ancora in una fase relativamente iniziale, ma hanno già prodotto sviluppi significativi: ad esempio, nel procedimento californiano contro Meta (riguardante l’addestramento del modello LLaMA), il giudice ha ridimensionato le accuse, dichiarando di voler respingere le contestazioni secondo cui il testo generato dall’AI violerebbe il copyright degli autori. In pratica, il tribunale ha ritenuto che i passaggi di testo prodotti dal modello non fossero abbastanza simili alle opere originali da costituire un’infrazione diretta. Resta però in discussione il cuore del problema, ovvero l’uso di libri piratati per l’addestramento: documenti interni di Meta emersi durante il processo suggeriscono infatti che il dataset di training includeva copie non autorizzate di migliaia di libri (ad esempio tramite la raccolta online LibGen) e che tale pratica fosse nota e approvata ai massimi livelli dell’azienda. Di fronte a queste rivelazioni, il giudice ha concesso agli autori la possibilità di presentare un esposto aggiornato, pur rimanendo scettico su alcune delle nuove pretese avanzate (come quelle basate su frode informatica). Complessivamente, le azioni legali degli autori contro OpenAI e i suoi partner rimangono in corso sia a New York sia in California, e rappresentano un banco di prova cruciale su come il diritto d’autore si applica ai modelli linguistici generativi.
Editori e media news:
Anche varie testate giornalistiche e gruppi editoriali hanno trascinato in tribunale le aziende di AI generativa per l’uso non autorizzato di articoli e notizie. Negli Stati Uniti, ad esempio, i proprietari dei siti di informazione Raw Story e AlterNet hanno fatto causa a OpenAI accusandola di aver usato migliaia di loro articoli per addestrare ChatGPT. In un primo momento, nel novembre 2024, una giudice federale di New York ha archiviato questa causa, ritenendo che gli editori non fossero riusciti a dimostrare un danno concreto sufficiente a sostenere l’azione legale (pur concedendo la facoltà di presentare un nuovo reclamo). Il tribunale si è detto “scettico” che i querelanti potessero articolare un’effettiva lesione giuridica, segnalando la difficoltà di quantificare il pregiudizio derivante dall’uso di articoli per il training di un’IA. Tuttavia, un caso parallelo promosso da The Intercept (un’altra testata online le cui notizie sarebbero state utilizzate da OpenAI) ha avuto esito differente: nel febbraio 2025 un giudice di Manhattan ha negato la richiesta di OpenAI di respingere la causa, riconoscendo che rimuovere le informazioni di gestione del copyright dagli articoli (come attribuzioni e note di copyright) potrebbe costituire un danno concreto ai diritti degli editori.
In questa causa, il giudice ha mantenuto in vita il nucleo dell’azione legale, divergendo deliberatamente dalla collega che pochi mesi prima aveva liquidato il caso Raw Story/AlterNet, e sottolineando come l’eliminazione dei metadati sul copyright incida su interessi proprietari tradizionalmente tutelati dal diritto d’autore. Oltre a queste vertenze, a fine 2023 si è aggiunto il primo grande nome della stampa: The New York Times, insieme ad altre testate (come il Boston Globe, il Denver Post e la News Media Alliance), ha intentato una causa federale contro OpenAI e il suo finanziatore Microsoft, accusandoli di sfruttare milioni di articoli pubblicati per addestrare i chatbot. Tali procedimenti dei media sono stati unificati in un unico caso di alto profilo, che a gennaio 2025 era già approdato a un’udienza chiave per decidere sull’eventuale prosieguo verso il dibattimento. Va notato che non tutte le testate hanno scelto la via giudiziaria: alcune, come l’Associated Press, News Corp. e Vox Media, hanno preferito stipulare accordi di licenza o condivisione di contenuti con OpenAI (mantenendo riservati i termini economici), mentre altre hanno optato per lo scontro legale. Questa divergenza di approcci riflette l’incertezza su come proteggere i contenuti giornalistici nell’era dell’AI: c’è chi tenta la collaborazione, e chi invece cerca un precedente legale che fissi dei limiti all’utilizzo di articoli protetti nei modelli generativi.
Artisti visivi e immagini generative:
Sul fronte delle arti visive, uno dei casi emblematici riguarda una class action promossa da illustratori e artisti contro i creatori di sistemi di generazione di immagini come Stable Diffusion e Midjourney. Nel 2023 le illustratrici Sarah Andersen, Kelly McKernan, Karla Ortiz e altri artisti hanno citato in giudizio Stability AI, Midjourney e la piattaforma DeviantArt, accusandole di aver saccheggiato milioni di opere d’arte dal web – comprese le loro – per addestrare modelli di sintesi d’immagine, il tutto senza ottenere consenso né riconoscere compensi agli autori. I querelanti sostengono che Stable Diffusion, il modello sviluppato da Stability AI e integrato in vari servizi, contenga essenzialmente “copie compresse” dei loro lavori creativi e ne riproduca elementi distintivi quando genera nuove immagini. Inizialmente il giudice federale William Orrick, incaricato del caso in California, ha accolto con scetticismo alcune delle teorie avanzate dagli artisti: nell’ottobre 2023 ha infatti rigettato molte delle accuse (incluse quelle di violazione del marchio e di diritti di pubblicità), ritenendole giuridicamente carenti, ma ha permesso di riformulare le denunce relative al copyright. Gli artisti hanno quindi presentato un esposto emendato e, nel maggio 2024, il giudice ha espresso l’intenzione di dare luce verde alla prosecuzione della causa sulla base delle violazioni del diritto d’autore ipotizzate. In udienza preliminare Orrick ha dichiarato che le dieci persone offese hanno esposto una rivendicazione plausibile: i convenuti potrebbero aver copiato e immagazzinato le opere protette degli artisti sui propri server, rendendosi potenzialmente responsabili di utilizzo non autorizzato delle stesse. Pur trattandosi di considerazioni provvisorie, il segnale è chiaro: la giustizia intende approfondire se e come un modello generativo di immagini possa infrangere il copyright delle opere visive impiegate nel suo addestramento. La questione del fair use – ossia se l’uso di immagini altrui per generare nuove opere sia “trasformativo” e legittimo – rimane sullo sfondo e non è stata ancora affrontata nel merito in questa fase. La causa degli artisti contro Stability AI e Midjourney è quindi entrata nella fase di scoperta degli atti (discovery), in cui le aziende convenute dovranno rivelare informazioni sul funzionamento dei loro sistemi e sui dati utilizzati, mentre si prepara un potenziale processo che potrebbe fare giurisprudenza nel campo dell’arte digitale generata dall’AI.
Fotografia e dataset di immagini:
Un capitolo a parte riguarda la causa avviata da Getty Images, colosso internazionale della fotografia stock, contro Stability AI per la presunta violazione su vasta scala dei diritti sulle sue immagini. Nel gennaio 2023 Getty ha intentato un procedimento civile presso l’Alta Corte di Londra sostenendo che Stability AI abbia “raschiato” milioni di fotografie dai siti Getty (insieme ai relativi metadati e didascalie) senza alcuna licenza, utilizzandole poi per addestrare il modello open-source Stable Diffusion. L’atto di citazione afferma che le immagini generate da Stable Diffusion potrebbero costituire opere derivate non autorizzate, riproducendo parti sostanziali delle foto originali, e segnala perfino casi in cui le creazioni artificiali avrebbero ricreato il watermark di Getty – un indizio del fatto che il sistema avrebbe memorizzato indebitamente elementi specifici dei contenuti Getty. Questo caso è uno dei primi di tale portata nel Regno Unito e viene seguito con attenzione per le sue possibili implicazioni sul diritto d’autore nell’era dell’AI. Finora, la High Court britannica ha respinto i tentativi procedurali di Stability AI di far cadere il cuore delle accuse: nel dicembre 2023 un giudice ha rifiutato di eliminare dal giudizio le contestazioni per violazione di copyright, violazione di database rights e trademark avanzate da Getty, ritendendo che vi fossero questioni sostanziali da esaminare in sede processuale. Allo stesso tempo, però, i giudici inglesi si sono mostrati prudenti riguardo alla gestione collettiva di tali reclami: nel gennaio 2025 la Corte (giudice Joanna Smith) ha negato a Getty la possibilità di procedere tramite azione rappresentativa per conto di oltre 50.000 fotografi contribuenti i cui scatti sarebbero stati utilizzati da Stability.
In base alla normativa inglese (CPR 19.8), Getty aveva proposto di far agire in giudizio come rappresentante comune la società Thomas M. Barwick Inc., uno dei fotografi i cui lavori sono concessi in licenza esclusiva a Getty. La Corte però ha stabilito che questa classe di soggetti non fosse sufficientemente definita e omogenea: non è attualmente possibile determinare con esattezza quali specifiche opere fotografiche siano state impiegate nell’addestramento di Stable Diffusion, né identificare agevolmente tutti gli autori coinvolti. Di conseguenza, il giudice ha ritenuto “impraticabile e sproporzionato” consentire un’azione collettiva in tali condizioni. Questo esito implica che Getty Images potrà far valere in giudizio solo le proprie foto (di cui detiene direttamente il copyright) o eventualmente coinvolgere singolarmente altri fotografi esclusivi, evitando però di rappresentarli in blocco. La decisione, pur essendo di natura procedurale, segna una battuta d’arresto per Getty sul piano strategico; ciononostante, il nucleo della controversia rimane intatto e il caso prosegue verso le fasi successive. L’aspettativa è che questa causa, qualora giunga a sentenza, possa tracciare una linea guida su come dovrà essere gestito il data mining di immagini protette nel campo dell’AI, quantomeno nell’ordinamento britannico.
Musica e IA: testi e composizioni sotto esame.
Anche il settore musicale è in fermento sul fronte legale, con numerose azioni promosse da editori musicali, società di gestione dei diritti d’autore e persino major discografiche contro sviluppatori di AI generativa. Un tema centrale è l’utilizzo di testi di canzoni e partiture protette per addestrare modelli linguistici o sistemi di generazione musicale. Nel 2023 tre grandi editori musicali statunitensi – Universal Music Group (UMG), Concord e ABKCO Music – hanno intentato una causa in California contro Anthropic, azienda creatrice del chatbot Claude, accusandola di aver inserito nei dati di training i testi di oltre 500 brani celebri (da Beyoncé ai Rolling Stones ai Beach Boys) senza alcuna licenza. Gli editori sostengono che Claude, se interrogato, possa restituire parti sostanziali di questi testi, dimostrando così l’avvenuta copia non autorizzata. In questo caso, a marzo 2025 è arrivata una prima decisione interlocutoria favorevole all’azienda di IA: il giudice federale Eumi Lee ha respinto la richiesta degli editori di imporre un’ingiunzione preliminare che avrebbe bloccato Anthropic dall’utilizzare testi musicali protetti durante il processo. La Corte ha giudicato la misura chiesta eccessivamente ampia e ha rilevato che i querelanti non hanno dimostrato un danno irreparabile imminente causato da Anthropic. In pratica, la richiesta di bloccare subito l’AI è stata considerata prematura, anche perché la questione cruciale – se l’uso dei testi nei dati di addestramento rientri nel fair use – è ancora aperta e sarà verosimilmente il punto decisivo del giudizio. Gli editori musicali si sono detti delusi ma fiduciosi nella prosecuzione della causa, mentre Anthropic ha accolto con favore il rigetto di un provvedimento che riteneva “disruptive e amorfo” per le proprie attività. Spostandosi in Europa, un caso epocale è rappresentato dalla causa avviata nel novembre 2024 da GEMA – la principale società di gestione dei diritti musicali in Germania – contro OpenAI. Si tratta della prima azione di un’organizzazione di collecting contro un fornitore di AI generativa a livello mondiale, e verte sull’asserita violazione di copyright relativa all’impiego di testi di canzoni tedesche nell’addestramento di ChatGPT. GEMA contesta la possibilità che OpenAI possa appellarsi alle eccezioni sul text and data mining previste dal diritto UE e tedesco, sostenendo di aver formalmente esercitato un opt-out per escludere il repertorio dei suoi associati da tali utilizzi. L’obiettivo dichiarato della causa è fare chiarezza su queste questioni aperte e promuovere l’adozione di un modello di licenza dedicato all’AI generativa, attraverso cui i detentori dei diritti musicali possano essere remunerati per l’uso delle loro opere nei dataset di training. Il procedimento è in corso in Germania e viene considerato un test case che potrebbe influenzare l’intero settore in Europa. Anche in India si registrano sviluppi simili: nel febbraio 2025 giganti dell’industria musicale indiana come Saregama e T-Series sono intervenuti in un procedimento legale già avviato contro OpenAI presso l’Alta Corte di Delhi, denunciando che i metodi di training di ChatGPT abbiano sfruttato testi di canzoni, composizioni e registrazioni musicali protette senza autorizzazione. In origine, questa causa era stata promossa dall’agenzia di stampa Asian News International (ANI) per l’uso non autorizzato di suoi contenuti giornalistici, ma si è rapidamente allargata attirando l’attenzione di editori musicali, case editrici librarie e organi di informazione in India. Ciò riflette un fronte comune emergente a livello globale: titolari di diritti di diverse tipologie che uniscono le forze per sfidare le aziende di AI sulle modalità di utilizzo dei contenuti protetti, sollevando interrogativi cruciali sull’applicabilità del fair use e di principi analoghi fuori dagli Stati Uniti.
Opere musicali e registrazioni audio:
Un altro filone di contenziosi nel campo musicale riguarda le registrazioni sonore e i brani musicali utilizzati per generare nuova musica attraverso l’AI. Nel giugno 2024, un gruppo di grandi etichette discografiche statunitensi – tra cui Universal Music, Sony Music e Warner Music – ha intentato cause per violazione di copyright contro due popolari piattaforme di generazione musicale con IA, Suno e Udio. Tali piattaforme sono accusate di aver “rubato” brani protetti da copyright per addestrare i loro modelli e di produrre musica che imiterebbe in maniera non autorizzata le opere originali. Secondo la denuncia depositata (annunciata dalla RIAA, l’associazione americana dell’industria discografica), Suno e Udio avrebbero estratto materiale da un vasto repertorio di canzoni famose, attraversando artisti, generi ed epoche diverse, al fine di alimentare i loro algoritmi generativi. Le case discografiche sostengono che questa condotta violi palesemente il copyright e chiedono il risarcimento dei danni – fino a 150.000 dollari per ciascuna opera utilizzata, secondo alcune fonti. La comunità musicale, pur interessata alle potenzialità dell’AI, ha espresso appoggio a queste azioni legali: “La comunità musicale ha abbracciato l’AI… ma possiamo avere successo solo se gli sviluppatori sono disposti a collaborare con noi in modo responsabile,” ha dichiarato Mitch Glazier, CEO della RIAA, aggiungendo che “servizi non autorizzati che affermano sia ‘lecito’ copiare il lavoro di una vita di un artista per sfruttarlo a scopo di lucro senza consenso o compenso compromettono la promessa di un’IA davvero innovativa per tutti”. Dal canto loro, le startup convenute respingono le accuse: il CEO di Suno, ad esempio, ha affermato che la missione della società è “rendere possibile a chiunque creare musica” e che la loro tecnologia sarebbe trasformativa, generando “output completamente nuovi, non destinati a memorizzare o rigurgitare contenuti preesistenti”. Udio, in una lunga nota pubblica, ha paragonato l’addestramento di un’IA musicale allo studio che compie uno studente di musica, sostenendo che il modello apprende concetti e idee musicali di base “che non sono proprietà di nessuno” e che non vi è interesse a riprodurre fedelmente alcun brano del dataset. La RIAA ha replicato definendo “sbalorditiva” tale giustificazione, ribadendo che Suno sarebbe stata “letteralmente colta sul fatto… a memorizzare e ripetere” registrazioni di artisti, e che la stessa difesa di Udio equivale a un “ammissione” di condotta illegale ed eticamente scorretta. Queste cause sono attualmente nelle fasi iniziali di dibattimento (presentate rispettivamente presso i tribunali federali del Massachusetts e di New York) e saranno seguite con attenzione, poiché potrebbero costituire i primi precedenti giudiziari sul rapporto tra AI generativa musicale e diritti discografici. Il loro esito potrebbe incidere profondamente sul modo in cui l’AI verrà utilizzata nella produzione musicale, imponendo forse nuovi limiti o procedure di licenza per proteggere gli artisti.
Codice software e GitHub Copilot:
Le dispute sull’AI generativa non riguardano solo contenuti creativi tradizionali, ma anche il codice sorgente. Un caso pionieristico in questo ambito è la class action intentata nel 2022 da un gruppo di sviluppatori contro GitHub Copilot, un assistente di programmazione basato su AI realizzato da GitHub e OpenAI. Copilot utilizza modelli linguistici addestrati su miliardi di righe di codice pubblico (principalmente proveniente da repository open-source su GitHub) per suggerire automaticamente frammenti di codice durante la scrittura di software. I querelanti sostengono che Copilot, così facendo, abbia violato le licenze open-source e il diritto d’autore, poiché in alcuni casi fornirebbe agli utenti stralci di codice presi dai progetti originali senza rispettarne le condizioni (ad esempio senza menzionare l’autore o la licenza, come richiesto).
La causa, avviata in California contro GitHub, la casa madre Microsoft e OpenAI, includeva ben 22 capi di accusa, dai profili di infrazione del copyright alla violazione di norme del DMCA (Digital Millennium Copyright Act) relative alla rimozione di informazioni di gestione dei diritti.
Nel corso del 2023 e 2024, tuttavia, il tribunale ha ridotto drasticamente la portata del contenzioso. Su istanza delle società convenute, il giudice distrettuale Jon Tigar ha progressivamente accolto molte eccezioni, eliminando la maggior parte delle rivendicazioni dei programmatori. In particolare, nel luglio 2024 è stata emessa un’ordinanza chiave che ha disposto l’archiviazione di ulteriori tre capi d’accusa, compreso quello relativo alla violazione della sezione 1202(b) del DMCA (che vieta di rimuovere o alterare informazioni sul copyright allo scopo di facilitare un’infrazione). Il giudice ha motivato tale decisione osservando che il codice suggerito da Copilot non è mai identico in modo sostanziale a quello dei querelanti – il modello tende a generare variazioni, seppur simili, anziché copiare pedissequamente – venendo così meno il presupposto per configurare una violazione di quella norma. Di fatto, i programmatori non sono riusciti a dimostrare esempi concreti in cui Copilot riproducesse integralmente un loro file di codice protetto, e le asserzioni sul rischio di futura “identicità” non sono bastate a tenere in piedi molte accuse. Al momento, dunque, la causa Copilot resta in piedi solo per due rivendicazioni residue su ventidue iniziali, il che rappresenta un importante successo per Microsoft, GitHub e OpenAI. Questo esito parziale suggerisce che, almeno in questo frangente, la giurisprudenza potrebbe essere orientata a non penalizzare eccessivamente gli strumenti di AI creativa quando il loro output risulta trasformato o de minimis rispetto ai dati di partenza – un’interpretazione che, implicitamente, strizza l’occhio all’innovazione tecnologica. Resta comunque da vedere se i ricorrenti porteranno nuovi elementi (o faranno appello) per far valere le proprie ragioni in futuro, dato che la questione del rispetto delle licenze open-source da parte delle AI rimane sentita nella comunità degli sviluppatori.
Altri fronti legali: diffamazione e responsabilità dei contenuti generati.
Oltre alle dispute in materia di copyright, stanno emergendo cause innovative che mettono alla prova la responsabilità legale dei sistemi di AI generativa per i contenuti che producono. Un esempio significativo è la prima causa per diffamazione intentata contro OpenAI: nel giugno 2023, il giornalista e conduttore radiofonico Mark Walters, della Georgia (USA), ha citato in giudizio la società dopo che ChatGPT aveva fornito a un terzo utente un riassunto completamente falso di un documento legale, affermando in modo diffamatorio che Walters era coinvolto in frodi ed appropriazione indebita di fondi. OpenAI ha cercato di far archiviare il caso sostenendo che l’utente stesso avesse istruito male il modello e sapesse della falsità delle affermazioni, ma nel gennaio 2024 un giudice statale della Georgia ha rigettato la mozione di OpenAI, consentendo alla causa di procedere. Si tratta di un procedimento senza precedenti, destinato a verificare se e in che misura un’azienda possa essere ritenuta responsabile civilmente per le allucinazioni della propria AI (informazioni inventate e potenzialmente lesive). Casi simili iniziano ad affiorare anche in altre giurisdizioni: nel marzo 2025 un uomo norvegese ha sporto denuncia dopo che ChatGPT aveva falsamente dichiarato (in risposta alla richiesta di un altro utente) che egli aveva ucciso due figli e scontato 21 anni di carcere. Queste vicende, pur differenti dalle questioni di diritto d’autore, segnalano un ulteriore terreno di scontro: quello della diffusione di informazioni errate o dannose generate dall’AI. Il dibattito legale si concentra sul se i modelli generativi possano essere considerati alla stregua di prodotti editoriali (e i loro creatori come editori responsabili di eventuali diffamazioni), o se invece godano di tutele simili a quelle delle piattaforme online che ospitano contenuti di terzi. Al momento non esistono precedenti definitivi, ma il fatto che le prime cause di questo tipo non siano state subito respinte suggerisce che i tribunali sono disposti a esplorare seriamente il tema. Le aziende di IA, da parte loro, osservano con attenzione: un’eccessiva esposizione legale per ogni inesattezza prodotta dai modelli potrebbe avere un effetto raggelante sullo sviluppo di chatbot avanzati, a meno di non introdurre correttivi o sistemi di verifica più rigorosi nelle risposte generate.
Stato attuale e prospettive
All’inizio del 2025, il panorama dei contenziosi sull’AI generativa è in pieno divenire. Gran parte delle cause descritte sono ancora pendenti, in attesa di giungere a sentenze di merito o possibili accordi extragiudiziali. Nonostante alcune pronunce preliminari (soprattutto su mozioni di dismiss o ingiunzioni) abbiano fornito indicazioni, i nodi giuridici centrali – su tutti la questione del fair use applicato all’addestramento dei modelli – non sono stati del tutto sciolti. Negli Stati Uniti, il principio del fair use consente l’utilizzo di materiali protetti senza licenza in certi casi di uso trasformativo, e le Big Tech vi fanno ampio affidamento per giustificare l’apprendimento automatico dai dati esistenti: aziende come OpenAI, Microsoft e Meta affermano che i loro sistemi apprendono dai contenuti altrui in modo trasformativo, creando qualcosa di nuovo e di valore che non sostituisce le opere originarie ma anzi ne espande le possibilità. Questo argomento, se riconosciuto valido, potrebbe fungere da scudo contro molte rivendicazioni di violazione. D’altra parte, autori e creatori evidenziano come il data mining massivo di libri, articoli, immagini o musica senza alcuna autorizzazione rappresenti una forma di sfruttamento non compensato del loro lavoro, e chiedono ai tribunali di intervenire per ristabilire un equilibrio. Alcuni tribunali hanno mostrato sensibilità verso i timori dei detentori di diritti (ad esempio lasciando che avanzino le accuse quando è plausibile che vi sia stata una riproduzione non autorizzata significativa), mentre altri sono apparsi cauti nel non ostacolare l’innovazione se il danno non è concretamente dimostrato o se l’output dell’AI non ripropone pedissequamente l’input originale.
Quel che è certo è che queste dispute legali faranno giurisprudenza. I casi contro OpenAI, Stability AI, Midjourney, GitHub Copilot e altri definiscono un campo di prova senza precedenti, i cui esiti potrebbero plasmare sia il futuro sviluppo dell’AI generativa sia le strategie di tutela dei creatori. Vi è un generale auspicio, anche da parte di osservatori e operatori del settore, che si possa giungere a soluzioni equilibrate – ad esempio attraverso licenze collettive per l’uso di grandi insiemi di dati creativi – capaci di conciliare l’innovazione con il diritto d’autore. In diversi procedimenti, i giudici stessi hanno riconosciuto la delicatezza del bilanciamento in gioco: nel negare provvedimenti troppo estesi o vaghi, alcuni hanno sottolineato come non esista ancora un mercato definito per la licenza di dati di addestramento e come intervenire senza criteri chiari rischierebbe di soffocare un settore nascente. Allo stesso tempo, il crescente numero di accordi privati tra aziende di media e sviluppatori di AI indica che una strada negoziale è possibile, parallela a quella giudiziaria, per distribuire i benefici dell’AI in modo più equo. In conclusione, il contenzioso sui modelli di AI generativa è in evoluzione e altamente sfaccettato, ma lascia intravedere un cauto ottimismo: la legge sta iniziando ad affrontare le sfide poste dall’AI, e le prime decisioni – pur proteggendo i diritti degli autori – sembrano riconoscere il valore dell’innovazione tecnologica, cercando di non soffocarla sul nascere. Sarà fondamentale osservare gli sviluppi nel 2025 e oltre, man mano che queste cause pionieristiche avanzano e che eventualmente i tribunali (o i legislatori) delineeranno regole più chiare per l’intelligenza artificiale generativa nel rispetto della creatività umana.