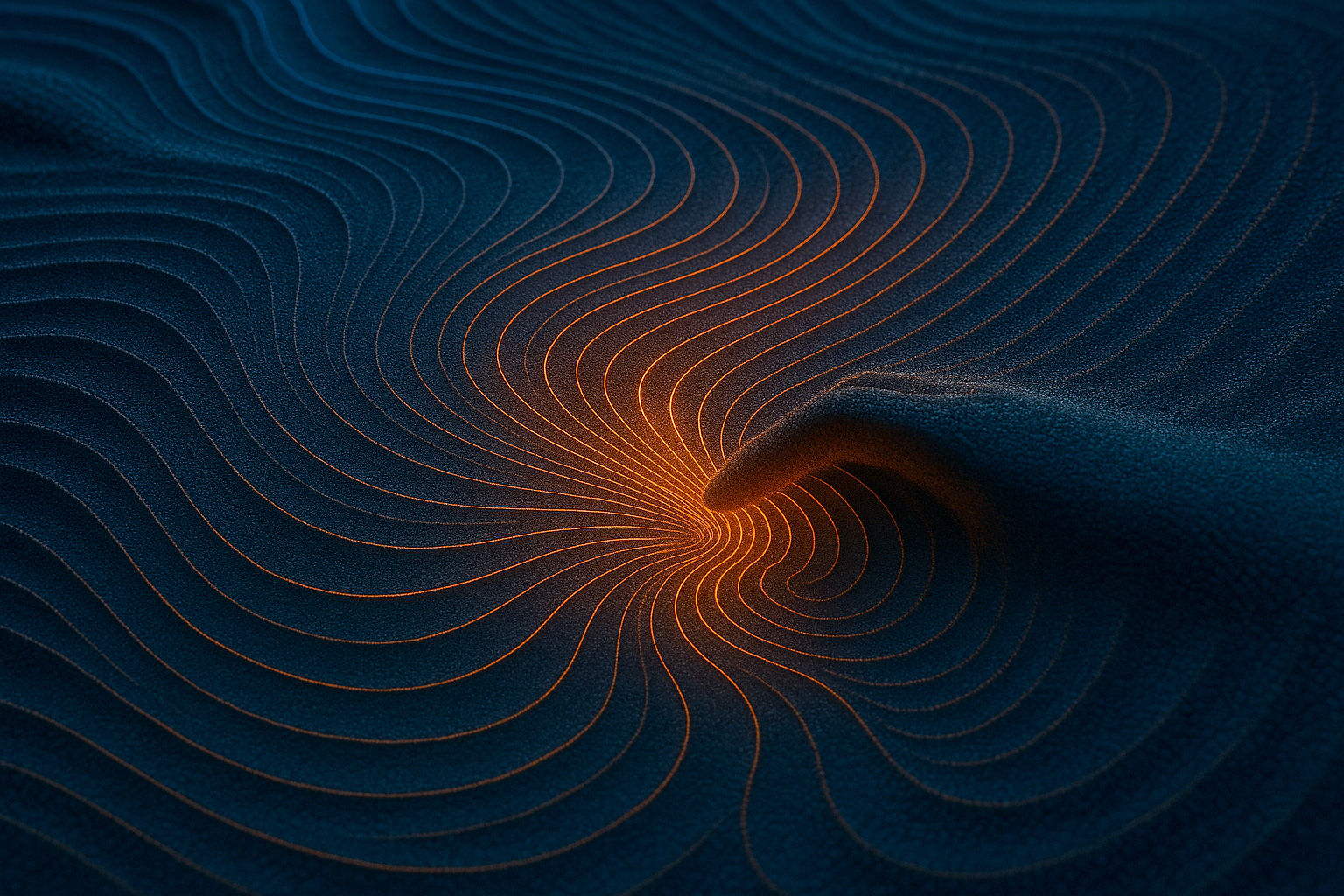Nel cuore della rivoluzione tecnologica, assistiamo a un paradosso curioso: più gli strumenti si affinano, più si rafforza una visione arcaica della creatività. È un Medioevo Digitale, dove le torce accese non bastano a illuminare il vero cambiamento in atto. In questo paesaggio di pixel e codici, resiste ostinata una convinzione che sfiora la superstizione: l’opera visiva generata digitalmente, se priva dell’intervento diretto della mano umana, sarebbe fredda, senz’anima, incapace di veicolare una reale espressione artistica. Poco importa la complessità dello strumento, la cura nella selezione degli input, la raffinata regia del processo: ciò che manca, dicono, è il tocco. Il gesto.
Ma che cos’è questo “tocco”, se non una proiezione romantica, un residuo ideologico dell’era analogica? Il tocco umano, celebrato come marchio d’autenticità, viene qui brandito come un feticcio, un filtro assoluto di legittimità artistica. Il problema non è nuovo. La fotografia visse lo stesso processo di esclusione ai suoi esordi, accusata di essere una pratica meccanica, incapace di suscitare emozione o visione. La storia si ripete oggi con le intelligenze artificiali generative, colpevoli di essere strumenti troppo potenti, troppo nuovi, troppo impersonali. Eppure, proprio nel dialogo tra l’essere umano e la macchina si apre un orizzonte creativo inedito, ancora largamente incompreso.
In questa nuova dimensione, l’artista non è più un demiurgo solitario ma un direttore d’orchestra invisibile, un architetto dell’intenzione che guida flussi di dati, codici, suggestioni. Non plasma la materia, ma le possibilità. Eppure il suo sguardo resta, in forma diversa, in ogni decisione presa: nella composizione, nella scelta dei riferimenti, nella modulazione dello stile. L’intelligenza artificiale generativa non sostituisce l’artista: lo costringe a ripensarsi. Ma questo passaggio, invece di essere accolto come un’opportunità di rifondazione estetica, viene percepito da molti come una minaccia. Da qui, l’erezione di muri concettuali, dogmi semantici, difese identitarie che odorano di paura, più che di amore per l’arte.
Il rifiuto quasi religioso verso ciò che non reca tracce visibili di imperfezione umana nasconde un’idea miope di autenticità. Come se l’opera non potesse contenere profondità senza l’errore. Come se l’immaginazione fosse una prerogativa esclusiva dell’essere umano, e non una funzione espandibile, replicabile, trasformabile attraverso altri linguaggi. È una forma di analfabetismo estetico, un’incapacità di leggere i segni del nuovo, di accogliere la possibilità che la bellezza possa nascere anche da una grammatica non umana, purché orchestrata da un’intelligenza sensibile, che può benissimo essere la nostra.
Questo Medioevo Digitale non durerà. Come tutte le fasi oscure, è destinato a cedere sotto il peso delle opere stesse, che lentamente riveleranno la loro forza, la loro intensità emotiva, la loro coerenza formale, anche quando sono il frutto di una collaborazione invisibile tra mente umana e reti neurali. A quel punto, il dogma si sgretolerà da sé. Ma fino ad allora, il rischio è di sprecare tempo prezioso in battaglie ideologiche, mentre il futuro dell’arte si sta già scrivendo altrove.