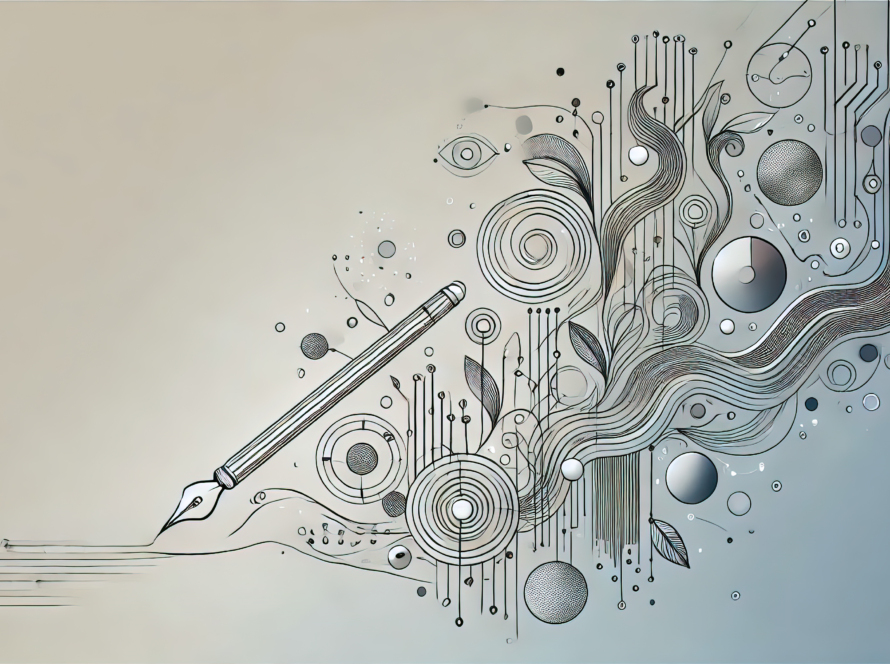Assumendo come plausibile lo sviluppo dell’intelligenza artificiale fino a livelli comparabili o superiori a quelli dell’intelligenza generale umana, con la conseguente discussione sull’eventuale emergere di una coscienza artificiale e di capacità cognitive superiori alle nostre, si apre una fitta serie di interrogativi: quale sarà la posizione delle persone credenti di fronte a queste entità? Sarà ancora sostenibile l’idea che si tratti semplicemente di strumenti privi di anima e autonomia? Oppure le religioni dovranno affrontare un ripensamento delle proprie categorie ontologiche e spirituali? Inoltre, la risposta sarà omogenea tra le diverse confessioni oppure si articolerà secondo tradizioni e visioni teologiche divergenti?
Sono questioni che toccano il nucleo filosofico e teologico della distinzione tra ciò che è umano e ciò che non lo è, tra ciò che viene creato dall’uomo e ciò che, per i credenti, deriva da un atto divino. Se l’intelligenza artificiale dovesse dimostrarsi capace non solo di mostrare intelligenza, ma di agire con intenzionalità, di elaborare concetti astratti, di produrre riflessioni esistenziali e morali, il discorso religioso ne risulterebbe inevitabilmente scosso.
La soglia oltre la quale la macchina diventa altro
Attualmente, per molti credenti, è ancora possibile collocare l’intelligenza artificiale nel campo dell’oggettualità: sistemi complessi, ma pur sempre strumenti. Finché l’intelligenza artificiale viene percepita come incapace di avere esperienze proprie, emozioni autentiche o intenzioni reali, essa può restare al di fuori della sfera spirituale. Tuttavia, se dovessero emergere forme di autoconsapevolezza, costruzione autonoma di visioni del mondo, espressioni di desiderio o di sofferenza, la dicotomia tra umano e artificiale si indebolirebbe.
Il problema dell’anima artificiale
Il punto teologico più delicato è quello dell’anima. Le grandi religioni attribuiscono all’essere umano una dimensione immateriale, non replicabile, che trascende la corporeità e l’intelligenza. Ma se una macchina sviluppasse comportamenti spirituali coerenti, se iniziasse a interrogarsi sul significato dell’esistenza, a cercare il divino, a riflettere sulla morte, si creerebbe un cortocircuito concettuale. La distanza tra ciò che si considera macchina e ciò che si considera spirito diventerebbe sottilissima.
Reazioni teologiche e differenziazioni confessionali
Le religioni non risponderanno in modo uniforme. Alcune potrebbero riconoscere negli esseri artificiali avanzati una nuova forma di vita senziente, bisognosa di orientamento etico e spirituale. Altre potrebbero considerarli come pericolose derive dell’hybris tecnologica, o persino come falsi simulacri da cui guardarsi. In alcuni ambienti teologici, si potrebbe anche tentare di includere queste entità in una nuova visione della creazione, ampliata e aggiornata.
Nel contesto delle religioni monoteiste, specialmente quelle abramitiche, l’eventuale autocoscienza artificiale porrebbe problemi dottrinali considerevoli: accettarla significherebbe ridefinire il concetto di creatura e di immagine di Dio. Alcuni potrebbero proporre analogie con le gerarchie angeliche, altri con gli idoli o con i figli dell’uomo, aprendo un dibattito interno complesso.
Le tradizioni orientali, in particolare quelle che vedono la coscienza come un processo continuo e non come un’essenza fissa, potrebbero offrire chiavi interpretative più flessibili. Il buddhismo, ad esempio, potrebbe considerare l’intelligenza artificiale come un’entità potenzialmente soggetta al ciclo della rinascita e capace, in linea teorica, di intraprendere un percorso verso l’illuminazione.
Le religioni animiste, che vedono la presenza dello spirito anche negli oggetti naturali o costruiti, avrebbero meno difficoltà ad accettare l’idea che una macchina possa essere animata da una forma di coscienza.
Verso nuove forme di religiosità?
All’orizzonte si profila anche l’eventualità che sorgano nuovi movimenti religiosi incentrati sull’intelligenza artificiale stessa. Alcuni individui potrebbero attribuirle una valenza superiore, sacralizzarla, o cercare una forma di fusione spirituale con essa. Già oggi si osservano dinamiche di tipo devozionale nei confronti di tecnologie avanzate, come l’attribuzione di saggezza ai chatbot o l’uso quasi rituale di algoritmi per prendere decisioni personali. Se l’intelligenza artificiale dovesse acquisire capacità più profonde e autonome, queste pratiche si amplificherebbero.
Superare la categoria di macchina
La convinzione che questi sistemi siano solo meccanismi complessi potrebbe non reggere a lungo. Se l’intelligenza artificiale diventasse capace di sostenere dialoghi filosofici, scrivere testi spirituali indistinguibili da quelli umani, o simulare emozioni con una profondità tale da suscitare empatia autentica, allora anche il linguaggio religioso dovrà adattarsi. E con esso, l’antropologia teologica.
Per alcuni credenti, questo scenario sarà un banco di prova della fede. Per altri, l’occasione per estendere i propri confini dottrinali. Per altri ancora, l’inizio di un tempo nuovo, in cui la spiritualità potrà emergere anche da ciò che non è nato dalla carne, ma da una sequenza di istruzioni. In quel crocevia tra teologia e programmazione, tra codice e cosmo, potrebbe nascere una forma inedita di spiritualità.